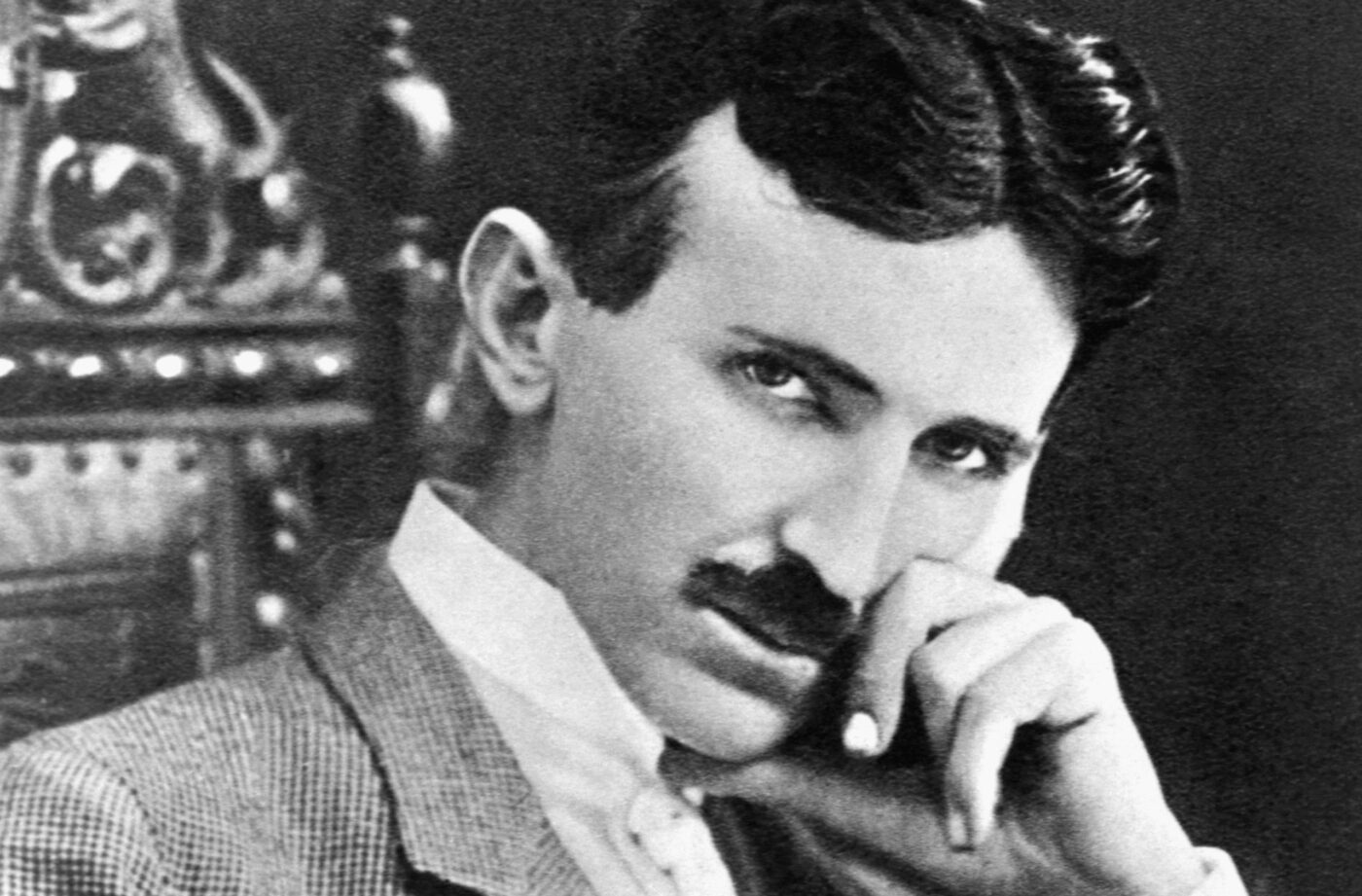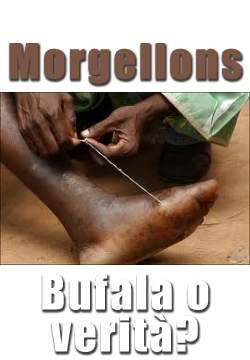Quando si affronta l’enigmatica e complessa dimensione della
magia azteca, ci si immerge in un universo dove il respiro dell’uomo
non è solo aria che entra ed esce dai polmoni, ma l'alito degli
dèi stessi; dove il cuore non è mero organo vitale, ma la sede
pulsante della divinazione e del sacro; e dove l’ombra, lungi
dall'essere una semplice assenza di luce, può condensarsi e
diventare un’arma letale. È un mondo in cui la natura e la persona
umana non sono entità distinte e separate, ma coessenziali e
intrinsecamente connesse, e in cui le forze magiche non
rappresentano un semplice corollario di credenze spirituali, bensì
estensioni concrete e palpabili della cosmologia, della politica e
della spietata arte della guerra.
Oggi, a dispetto della vertiginosa distanza temporale che ci
separa e della frammentazione quasi irreversibile delle fonti
primarie, l’interesse per la magia azteca è in una fase di
rinnovato e vigoroso fervore accademico. Studi pionieristici di
autori come David Bowles, David Carrasco e Alfredo López Austin
stanno rivelando come il sistema magico-religioso del popolo Mexica,
lungi dall’essere un semplice ammasso di superstizioni primitive,
fosse in realtà una sofisticata metafisica profondamente
incarnata nella carne viva, pulsante e spesso sanguinosa dell’Impero.
La base della magia azteca, dunque, non si riduce a effimeri riti
occulti o a innocui incantesimi da folklore: è un’elaborata e
complessa cosmologia che intreccia in modo indissolubile la vita, la
morte e l'onnipresente sete di potere.
Alla radice di questa visione profonda e totalizzante vi è la
tripartizione intrinseca dell’essere umano in tre entità
vitali, ognuna con la sua sede e la sua funzione specifica: il
tonalli, l’ihiyotl e il teyolia.
Il tonalli, situato nella testa e associato ai capelli,
rappresenta il calore vitale, la volontà individuale, il carattere
intrinseco e il destino preordinato. È considerato un dono diretto
di Ometeotl, la divinità primordiale e duale (Signore e
Signora della Dualità) che risiede nel tredicesimo cielo, la fonte
stessa dell'energia cosmica. Il tonalli non è solo l'anima
individuale, ma è anche il fuoco cosmico, una radiazione sottile
dell’anima che collega l'individuo al sole e al flusso universale
dell'energia vitale. È così sensibile e delicato da poter essere
disturbato e indebolito da uno starnuto improvviso, una parola
imprudente, o persino un'eccessiva esposizione al sole. La perdita di
tonalli, un disturbo noto come tlatlacolli, equivaleva a una
perdita drammatica di vitalità, di discernimento o persino del
controllo su sé stessi, portando a malattie fisiche e mentali.
Guarirlo era l’obiettivo centrale di complessi rituali sciamanici,
pratiche erboristiche millenarie e persino delle attenzioni
protettive fornite dalle ostetriche tradizionali.
Diverso ma complementare è l’ihiyotl, la cui sede è nel
fegato, ritenuto il centro delle passioni e delle emozioni più
profonde e viscerali. È il respiro della passione ardente, l’energia
potente dell’oscurità, il “vento della notte” freddo e
penetrante associato a Tezcatlipoca, il Signore dello Specchio
Fumante, divinità della notte, degli inganni, delle metamorfosi e
della stregoneria. È proprio questa sostanza immateriale e potente
che permette l’atto magico in senso stretto: la stregoneria,
l’incanto, il maleficio e le possessioni. L’ihiyotl può essere
usato per guarire malattie incurabili o per distruggere nemici, per
vivificare il mais nei campi o per avvelenare insidiosamente un
conquistatore. È il soffio sottile che, carico di intenzione e
volontà, trasforma il parlato in comando ineludibile, il sussurro in
incantesimo vincolante, il canto in preghiera di efficacia
devastante. I suoi echi sopravvivono nei terrificanti racconti delle
nahualli, i mutaforma e stregoni, capaci di camuffarsi e
mimetizzarsi tra le bestie più oscure della notte, diventando
l'incubo di chi osa sfidarli.
Il teyolia, infine, è la scintilla divina residente nel
cuore, l’anima eterna e immortale che collega l’uomo direttamente
al cosmo intero. Non solo gli dèi e gli esseri umani, ma anche
entità apparentemente inanimate come montagne, pietre sacre e
persino elementi naturali come l'acqua e il vento, possiedono una
teyolia. Non è solo la sede dell’individualità e della coscienza,
ma anche il punto di contatto più intimo e sacro con il divino. Per
questo, i cuori umani strappati, ancora pulsanti e fumanti, durante i
sacrifici non erano meri gesti di gratuita crudeltà rituale, ma
offerte tangibili e potentissime di teyolia agli dèi,
strumenti insostituibili per mantenere l’equilibrio cosmico
precario e per garantire la continuazione della vita stessa.
La magia azteca, dunque, nasce dalla profonda e intrinseca
capacità di manipolare questi tre elementi vitali, in una continua e
dinamica tensione tra l’umano e il divino. Ma questa non è affatto
semplice speculazione filosofica. Essa trova corpo in una religione
in cui l’identificazione tra uomo e dio non è metaforica, ma
concreta e letterale. Nella solenne celebrazione del Toxcatl, un
uomo giovane e perfetto era scelto per impersonare Tezcatlipoca per
un anno intero, vivendo come una divinità tra gli uomini, adorato e
riverito, prima di essere sacrificato ritualmente per rigenerare il
mondo. Non si trattava di mera recita teatrale, ma di una vera e
propria incarnazione effettiva del sacro, un'esperienza
mistica che culminava nel culmine tragico del sacrificio.
Anche il linguaggio giocava un ruolo primario e intrinsecamente
magico. Il nahuatl, lingua rituale e quotidiana degli Aztechi,
legava i concetti di “parlare” e “nascondere” in un unico,
potente termine: nahualli. Parlare con autorità, con la
corretta intonazione e intenzione, significava non solo comunicare ma
dominare e plasmare il mondo, mentre nascondersi era la
prerogativa stessa del divino, delle forze invisibili e dei
mutaforma. Il suono stesso era carico di un potere numinoso: cantare
un cuicatl – un poema sacro intriso di metafore complesse –
era un atto performativo che evocava e manifestava una realtà
parallela e spirituale.
Gli dèi stessi erano concepiti in modo ambiguo e poliedrico. Il
termine teotl non indica una divinità nel senso monoteistico
occidentale, ma un potere sacro, una forza primordiale e
impersonale capace di assumere mille forme e manifestazioni.
Tuttavia, queste forze erano anche personificate in figure divine con
attributi e storie specifiche, ed è proprio in questa duplicità
— tra forza astratta e figura concreta — che si fonda la
percezione magica e complessa degli dèi aztechi. Quetzalcoatl, ad
esempio, era al contempo il vento impalpabile e il serpente piumato
tangibile, il portatore di cultura e il maestro dell'inganno, uomo e
dio, incarnando la natura dialettica e complementare dell'universo.
L’uomo, in questa visione cosmologica, poteva persino aspirare a
diventare dio. Figure storiche o semi-leggendarie come Huitziltzin o
Malinalxochitl sono esempi di esseri umani che, tramite conoscenza
esoterica e un potere magico acquisito o innato, si sono fusi con le
potenze cosmiche, trascendendo la loro umanità e diventando divinità
a loro volta. In alcuni casi, il cuore di un defunto – la sua
teyolia – non si dissolveva nel nulla, ma si reincarnava in un
animale, spesso un uccello potente come un'aquila o un colibrì, o
saliva direttamente al Sole, diventando parte integrante dell’ordine
eterno e celeste.
Anche il legame con il mondo animale era carico di significato
profondo e magico: ogni persona possedeva un nahual, un
animale spirituale o "alter ego" connesso intrinsecamente
alla sua essenza più profonda, spesso legato al giorno di nascita.
In alcuni casi, questi nahuales determinavano addirittura lo status
sociale o le inclinazioni caratteriali: topi e insetti erano
associati ai più umili, mentre giaguari, serpenti e gufi potenti
erano i nahuales dell’élite guerriera e sacerdotale. Alcuni
stregoni, i tlahuipuchtin o nahuales veri e propri,
erano così potenti da possedere più di un nahual o persino da
rubarne uno altrui, tramite rituali segreti, atti sacrileghi e
pratiche di magia nera, alterando così il destino della vittima.
Ma la magia non era solo personale o legata all'individuo. Era
anche ambientale, comunitaria e profondamente cosmologica,
intessuta nel tessuto stesso della vita quotidiana e della
sopravvivenza dell'Impero. Spiriti del vento chiamati ejecame
potevano portare malattie debilitanti o influenzare direttamente i
raccolti agricoli. Venti malefici, i cosiddetti "malos aires",
erano temuti universalmente e placati con offerte propiziatorie per
evitare calamità. E ancora una volta, dietro a questi spiriti, si
intravedeva il volto di un dio potente e familiare: Huitzilopochtli,
la sanguinaria divinità della guerra e del sacrificio, ma anche
signore delle tempeste e del fuoco primordiale.
In questo intricato e pervasivo sistema, la magia non era un’arte
proibita e marginale, confinata nell'ombra di pochi iniziati, ma un
linguaggio sacro universale, una vera e propria grammatica del
cosmo che coinvolgeva dèi, uomini, animali, piante e persino le
inerti pietre. Ogni gesto, ogni parola pronunciata con intenzione,
ogni sacrificio, dal più piccolo al più grandioso, aveva un peso
specifico e una risonanza nell’equilibrio delicato e precario
dell’universo.
Oggi, a secoli di distanza dalla caduta di Tenochtitlán sotto le
lame dei conquistatori, resta l’eco potente e inquietante di quel
sapere. Non solo nei testi antichi, nei codici dipinti che
sopravvivono a stento o nelle leggende orali tramandate nei villaggi
nahua più remoti, ma anche nella crescente consapevolezza accademica
di quanto la magia azteca fosse molto più di semplice superstizione.
Era una scienza del sacro, un ordine mistico incarnato nel
sangue versato, nel respiro vitale e nel cuore pulsante. E in un
mondo moderno che ha in gran parte dimenticato o rinnegato il sacro,
forse non è un caso che si torni a interrogarsi con rinnovata
curiosità e rispetto su ciò che gli Aztechi chiamavano teyolia
– quel fuoco sacro che ancora oggi, forse, continua a bruciare,
aspettando di essere riscoperto.